Dalle montagne “maledette” del Kelmend alle Bocche di Cattaro con Confluenze a sudest-Viaggi e Miraggi
1: Ritorno a Tirana
Venerdì 26 agosto 2022
Tirana è una città giovane: diventata una vera città solo nel 1600, è stata abbastanza irrilevante fino al XX secolo, quando il Congresso di Lushnjë la proclamò capitale d’Albania in seguito alla dichiarazione di indipendenza albanese dagli ottomani nel 1912. Ma non è giovane solo per questo, è giovane perché è giovane la sua popolazione, che oggi è di circa 900.000 abitanti, ma supera abbondantemente il milione se si tiene conto della popolazione non censita in quanto non residente. La città cresce a un ritmo di 50 persone al giorno, 20 mila l’anno (molti arrivano dalle campagne, altri sono emigrati di ritorno). Ed è una città che cambia velocemente, piena di cantieri che fanno sorgere nuove costruzioni a ritmo vorticoso. Anche in un tempo breve come tre anni, te la puoi ritrovare molto diversa. E proprio tre anni sono passati dalla mia precedente visita, che era anche la prima e che segnava l’inizio di un tour dell’Albania. Questa volta, invece, sono qui per iniziare un nuovo tour balcanico, che ci porterà da qui al Montenegro passando per le aspre montagne del Kelmend, nel nord dell’Albania, una parte del territorio albanese ancora abbastanza isolata e decisamente fuori dalle rotte del turismo di massa. È una parte che ancora mi manca, perché anche in quel precedente viaggio, che durava una decina di giorni, non eravamo riusciti a includerla. La firma – se qualcuno di voi mi segue lo avrà già capito – non può che essere ancora una volta quella del mio (e nostro) amico Eugenio Berra, amato “pusher” di viaggi balcanici sotto le insegne di Viaggi e Miraggi con la sua creatura Confluenze a sudest. Dico nostro perché sono qui con un gruppo di otto persone che è composto da un’ossatura di “fedelissimi” di Eugenio (Patrizia, Piera, Rina, Rosa, Rossella ed io), alla quale si aggiungono questa volta due new entry: Giorgia da Palermo e il mio compagno di stanza Carlo da Napoli. Con Carlo andiamo subito molto d’accordo: ci divide solo il tifo calcistico. Lui è un napoletano interista, quindi la “colpa” è un po’ sua… 😉
La mia sensazione quindi, al di là della poca lucidità dovuta alle poche ore di sonno (stamattina la sveglia è suonata alle 5), è un po’ di spaesamento; è quella di alzare gli occhi e chiedermi continuamente: ma quella specie di grattacielo c’era già? E quello che sembra un centro direzionale? E quell’enorme hotel?



Per fortuna a fare da trait d’union tra questo nuovo approccio alla città e il mio precedente viaggio albanese c’è Nida (Eronida, ma noi l’abbiamo sempre chiamata Nida), colei che tre anni fa fu la nostra guida per tutto il percorso. Vederla per me è una piacevole sorpresa, che mi fa tornare immediatamente alla memoria balli scatenati e spassosi battibecchi tra lei e un compagno di viaggio di allora, il mitico Giampi (anche lui napoletano) al quale lei non mancava mai di ricordare “Guarda che tu sarai anche napoletano, ma io sono albanese!”.
Ma bando alle ciance e ai ricordi, dobbiamo parlare di questo nuovo viaggio, che si annuncia assai interessante: sarà una sorta di completamento del precedente percorso albanese, e in più farò finalmente conoscenza con il Montenegro, un paese piccolo ma che ha sempre esercitato su di me un certo fascino, e che pur nella sua limitata estensione riunisce paesaggi, caratteri e culture molto diversi e variegati. Ne parleremo a tempo debito.
Ora, dopo un pranzetto veloce, dobbiamo iniziare a prendere, o riprendere, confidenza con la capitale albanese, e per farlo è quasi inevitabile partire dall’immensa Piazza Skanderbeg, dedicata all’eroe nazionale albanese, colui che nel XV secolo riunì i principati albanesi per frenare l’impetuosa avanzata dei turchi, e ci riuscì per molti anni. Morì nel suo letto, una stranezza per un guerriero come lui ma anche un punto d’onore: non riuscirono a sconfiggerlo e ucciderlo in battaglia, fu solo una malattia (forse malaria) a vincerlo. Poco dopo la sua morte, i turchi presero definitivamente il sopravvento, e non se ne andarono fino al 1912. Gjergi Kastrioti (o Giorgio Castriota in italiano) era il suo vero nome, ma si dice che l’appellativo di Skanderbeg fosse un diretto riferimento ad Alessandro Magno, dato che Iskender in turco corrisponde grosso modo ad Alessandro e Beg è un titolo nobiliare.
Le dimensioni di questa piazza, che si estende per cinque ettari nel cuore di Tirana, e le sue architetture raccontano l’epoca del regime comunista di Enver Hoxha e la sua megalomania. Si può ancora immaginare l’esercito sfilare per mostrare la potenza del regime.
Alla sua inaugurazione la piazza aveva solo un grande cippo in pietra con scolpita la data dell’indipendenza albanese, il 1912. Con l’avvento del socialismo, nella piazza furono poste la statua di Lenin e quella del dittatore Enver Hoxha, poi distrutte dal popolo in rivolta nel 1992.
La piazza prese l’attuale nome nel 1968, quando, nel cinquecentenario della sua scomparsa, vi fu collocato il monumento equestre di Skanderbeg, opera in bronzo dello scultore albanese Odhise Paskali.
Concepita inizialmente nel centro storico di Tirana da re Zog I secondo lo stile neo-razionalista, fu ampliata negli anni tra il 1920 e il 1930 sotto il protettorato fascista del Regno d’Italia. Successivamente, nel periodo comunista (dal 1945 al 1992), fu rimodellata secondo gli ideali correnti del regime: ampi e ordinati viali che da essa si dipartono costituiscono il centro cittadino e conducono a vari edifici pubblici, all’università, alla galleria d’arte contemporanea e al maestoso Mausoleo Piramidale progettato per l’allestimento di un museo dedicato alla vita di Enver Hoxha (ora prosaicamente divenuto centro fieristico, ricreativo e bar, in clima di dissacrazione totale). Nel 2017 la piazza è stata completamente ristrutturata e 24.000 m² della sua superficie sono stati pavimentati con un mosaico di pietre naturali provenienti da tutte le terre di lingua albanese, compresi il Kosovo e la Macedonia, con la presenza di aree verdi che si interpongono tra i vuoti lasciati dagli edifici, delimitando il perimetro della piazza.
L’Albania è ancora fuori dall’Unione Europea, ma lo scorso 19 luglio, dopo otto anni di attesa, ha finalmente partecipato alla prima conferenza intergovernativa in qualità di paese candidato.
Tutti sappiamo che l’Albania è il paese delle aquile, ma perché? Lo dice la parola stessa, come diceva qualcuno. Il nome dell’Albania in albanese è infatti Shqipëria, che si pronuncia grosso modo sciperìa e che significa proprio “paese delle aquile”. Un’aquila bicipite, infatti, campeggia sulla bandiera albanese, su uno sfondo rosso che rappresenta il sangue versato per la patria. Un’aquila bicipite si trova però anche sulla bandiera del Montenegro, ed ecco spiegato il titolo di questo racconto: Le aquile dei Balcani. L’aquila bicipite è un simbolo bizantino, per questo si trova in varie bandiere di nazioni che guardano a Oriente. Secondo alcuni autori una testa rappresenta l’Occidente e l’altra l’Oriente, in particolare le due metà dell’Impero bizantino, una in Europa e una in Asia.
In italiano, come un po’ in tutte le altre lingue europee, il nome Albania-albanese dato a questa terra e al suo popolo deriva appunto dal fatto che si trattava di un popolo che veniva da oriente, cioè dall’alba, da dove il sole nasce.
E Hoxha (che si pronuncia ogia), forse l’albanese più famoso di sempre, più dello stesso Skanderbeg? Hoxha è un cognome molto diffuso in Albania (certo – lo sanno tutti – è anche il vero cognome di Anna Oxa, che poi l’ha italianizzato) e significa imam.
La presenza italiana qui, come ovunque in Albania, è forte. C’è una zona industriale con stabilimenti di diverse aziende italiane, ma non solo: a Tirana c’è un Piano di rinascimento urbano firmato dall’architetto milanese Stefano Boeri. Promosso dal governo centrale e progettato in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, TR030 (si chiama così perché l’orizzonte è il 2030) fa parte di un programma che investe tutte le maggiori città albanesi, ma che in Tirana trova forse la cartina di tornasole: una città e una regione che, dopo la caduta del regime comunista di Enver Hoxha nel 1991, hanno vissuto un decennio di caos istituzionale e urbanistico in cui l’affermazione di un “ritrovato” diritto alla proprietà privata si è tradotta sostanzialmente in una sregolata rincorsa alla costruzione e dilapidazione di grandi porzioni di territorio.
Per quanto Edi Rama, socialista, sindaco di Tirana dal 2000 al 2011 e attuale primo ministro albanese, abbia cercato di arginarne gli effetti, mettendo in atto interventi di riassetto del suolo e recupero di spazio pubblico, l’espansione edilizia ha tuttavia continuato a tracimare nei comuni limitrofi. Ciò anche a causa di un punto debole, strutturale, che è stato individuato nell’assenza di un’autorità di governo metropolitano. La riforma amministrativa del 2014 ha colmato quell’assenza, e da qui si è ripartiti con un’altra cornice: i nuovi confini di Tirana ne hanno infatti espanso il territorio di venticinque volte, includendo identità estremamente differenti, aree peri-urbane scarsamente popolate, centri satellite con specifiche potenzialità. Una “città caleidoscopica” che, tuttavia, dovrebbe poter contare oggi su un nuovo strumento per una sua gestione possibilmente coordinata e di più ampio respiro.
«La strategia principale – ha spiegato Stefano Boeri – propone un necessario e non più prorogabile contenimento del consumo di suolo, la discontinuità nel tessuto urbano, la frammentazione dell’edificato, eventualmente lo sfruttamento di una certa verticalità per liberare terreno ulteriore. Tirana è una città con altezze medie non elevate, ma una densità tra le maggiori d’Europa, come se fosse stata compressa sacrificando tutti gli spazi aperti».
Dovrebbe essere la continuazione di quello che lo stesso Rama, che – non dimentichiamolo – è anche un artista, fece anni fa da sindaco, cercando di ridisegnare gli spazi della città a partire dai colori degli edifici. L’atto di colorare i palazzi per lui è stato un’azione politica: il grigio rappresentava l’oppressione del regime comunista, mentre i colori la speranza e la rinascita.
Nella piazza la statua di Skanderbeg e la moschea, curiosamente, sono piuttosto vicine: la più importante moschea della città, quella di Ethem Bey, e davanti la statua dell’eroe simbolo della lotta dei cristiani contro gli invasori musulmani, per questo addirittura gratificato dal papa di Roma del titolo di “difensore impavido della civiltà occidentale”.
Nida ci racconta che in effetti, soprattutto in occasione del Ramadan o di cerimonie molto partecipate, non sono mancate le polemiche per i devoti musulmani che pregano col sedere all’aria fuori dalla moschea proprio davanti allo sguardo di Skanderbeg. Tant’è che poi si è deciso, forse non del tutto casualmente, di chiudere la moschea per restauri nel marzo 2018. Dopo 27 anni, quindi, l’edificio simbolo dell’Islam albanese ha richiuso i battenti come durante il regime comunista quando, diversamente da altre moschee trasformate in magazzini, era rimasto un monumento culturale conservato dallo Stato. La moschea è stata poi riaperta nel 2020.
Il restauro della moschea è stato curato dalla TIKA (Agenzia di Cooperazione e Coordinamento Turca), un’istituzione del governo turco che promuove progetti di assistenza a paesi in via di sviluppo e in particolare alle comunità turche e islamiche in genere.
La costruzione della moschea venne iniziata nel 1789 da Molla Bey e completata nel 1823 da suo figlio, Haxhi Ethem Bey, discendente di Sulejman Pasha. Bey è una diversa traslitterazione di Beg, che come già detto in turco è un titolo nobiliare. Gli affreschi all’interno e all’esterno dell’edificio contengono delle particolarità: vi sono disegnati alberi, cascate e ponti, motivi che si vedono raramente nell’architettura islamica, proprio perché sono stati dipinti da maestranze non musulmane, per essere precisi da veneziani. Nel ’92, quando sono arrivati gli specialisti di arte religiosa incaricati di gestire la riapertura delle moschee, hanno visto questa stranezza: nelle decorazioni non c’era nessun simbolo tipico dell’arte religiosa islamica, come i nomi di Allah e dei profeti scritti in motivi calligrafici arabi, ma c’erano questi elementi più “occidentali”. Un segno, dice Nida, che la conversione dei nobili e dei potenti locali all’Islam era un fatto più che altro di convenienza, non c’era in loro una grande convinzione e un grande trasporto verso questa religione.
Nel 1991 10.000 persone, coraggiosamente vista l’opposizione delle autorità, decisero di entrare nella moschea per pregare, e la polizia non intervenne. L’evento fu una pietra miliare nella rinascita delle libertà religiose in Albania.
Secondo stime che risalgono a quasi ottant’anni fa, quindi a un censimento organizzato dagli occupanti italiani, i musulmani sarebbero il 70 per cento della popolazione, gli ortodossi il 17 e i cattolici il 10. Ma dopo mezzo secolo di comunismo e ventidue anni di proibizione assoluta di ogni manifestazione religiosa (l’Albania fu dichiarata “Stato ateo”), gli albanesi si ritrovarono disorientati, e molti non hanno ancora superato questo disorientamento. Anche chi è musulmano lo è in genere in modo piuttosto “laico”. Gli albanesi – dice Nida – sono in genere tolleranti riguardo alla religione. La cosa a cui invece tengono realmente, più di tutto, è la loro identità: la bandiera, quella sì, non si tocca.



Un segno del tentativo di instaurare una memoria storica degli anni del comunismo è la trasformazione in museo di uno dei bunker costruiti dal regime di Hoxha. Bunk’ Art 2, aperto il 17 novembre 2016, si trova nel centro della città, dietro il Ministero dell’Interno.
Il bunker è stato costruito dal 1981 al 1986 ed era concepito per ospitare la polizia d’elite e il personale del Ministero dell’Interno in caso di un eventuale attacco nucleare. Nel museo ora si trovano immagini, accessori ed oggetti che ricordano i crimini della persecuzione comunista, che ha interessato circa 100 mila albanesi fino al 1991.
Furono molte migliaia i bunker costruiti in Albania dal regime dittatoriale di Enver Hoxha, per far fronte ad un’eventuale invasione da parte dei paesi imperialisti come gli Stati Uniti, ma anche dall’Unione Sovietica dopo che nel 1968 l’Albania era uscita dal Patto di Varsavia, chiudendosi completamente. Furono progettati, si dice,
700.000 bunker, ma secondo il governo albanese “solo” un totale di 175.000 sarebbero stati effettivamente costruiti.




Un altro bunker, insieme con un pezzo del muro di Berlino, fa parte dell’installazione “Postbllok” (Checkpoint), eretta nel 2013, anch’essa come memoriale del periodo dell’isolamento comunista.


Un altro landmark dell’attuale paesaggio cittadino è la Nuvola, una sorta di padiglione in metallo e cristallo creato dell’architetto giapponese Sou Fujimoto. Questa grande installazione dal 2016 è situata nel giardino della Galleria Nazionale d’Arte e utilizzata come spazio artistico per eventi culturali di vario genere. Una serie di strutture in acciaio, a sezione quadrata due per due centimetri, si susseguono creando un ambiente sperimentale in cui vengono messi in discussione tutti i concetti dell’architettura tradizionale: interno ed esterno, muro e finestra, opacità e trasparenza.

Una figura onnipresente in Albania è quella di Madre Teresa. Ebbene sì, per chi non lo sapesse Madre Teresa di Calcutta, al secolo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, era albanese, nata il 26 agosto 1910 a Skopje (allora Impero ottomano, odierna capitale della Macedonia del Nord) da genitori albanesi originari del Kosovo.


Ci sarebbe molto da esplorare a Tirana, ma noi abbiamo in programma il primo di una serie di incontri che avremo durante questo viaggio: è quello con la scrittrice Vera Bekteshi, per il quale dobbiamo dirigerci al Bllok.
Il Bllok è un quartiere di villette risalenti agli anni Venti, Trenta e Quaranta, che ospitarono prima la goffa corte di Re Zog, l’autoproclamato monarca albanese del periodo tra le due guerre, poi i gerarchi fascisti e poi, per quarant’anni, quelli comunisti. Questo è quello che scrive il giornalista Antonio Caiazza nel suo libro “In alto mare”, un reportage di viaggio in Albania (di diversi viaggi, in realtà) che racconta questo paese nella lunga transizione dal comunismo al futuro:
“Il Bllok è un quadrilatero al di là del torrente Lana, in pieno centro. Una volta lungo il perimetro di questo quartiere c’erano le garitte dell’esercito. All’interno, le villette dei dirigenti. Compresa quella di Enver Hoxha.
«Quando ha fatto chiudere il Bllok, noi ex partigiani ci siamo detti: “Ma che cosa sta facendo? Non abbiamo combattuto per questo”. Fu una cosa che non ci piacque per niente» ricorda Alì quando gli racconto che cosa c’è oggi nel quadrilatero.
La “città proibita” è piena di pub, ristoranti, night, pizzerie, paninoteche, locali dai quali immancabilmente esce musica, con i tavoli fin sul marciapiede, le luci soffuse e tanti giovani che chiacchierano, ridono, amoreggiano.”
E ora il Bllok è effettivamente questo, è difficile vedere le tracce di quello che è stato. Si può vedere anche la villa di Enver Hoxha, ma se non ne conosci la storia può sembrare una villetta come un’altra in mezzo a un quartiere di bar e locali.



Eppure, se si riesce a guardare oltre, a immaginare, a silenziare tutto quello che c’è intorno, il Bllok può ancora raccontare le sue storie. Una di queste è quella di Vera Bekteshi e della sua famiglia. Vera Bekteshi è l’autrice de “La villa con due porte”, un romanzo autobiografico che sicuramente consiglio e che va oltre la storia di una famiglia; è la storia di una generazione che è cresciuta in quel quartiere sapendo di avere dei privilegi ma sapendo anche che in pochi convulsi giorni si poteva perdere tutto, come successe a lei quando suo padre, il generale Sadik Bekteshi, ex comandante partigiano del nord, cadde improvvisamente in disgrazia e fu accusato senza motivo di golpismo. Era il metodo seguito da Hoxha, quello di tarpare le ali con periodiche purghe a quelli che avrebbero potuto mettere in pericolo il suo potere, e terrorizzare tutti gli altri. Senza spoilerare troppo vi riporto poche righe, in cui Vera racconta un episodio che precede la purga che colpì suo padre e che fa capire il clima in cui si viveva all’università, dove lei studiava fisica, nel 1967, in piena epoca “cinese”:
“In questo quadro di rivoluzionarismo, nella vita del paese iniziarono ad apparire forme e metodi mutuati direttamente dalla Cina socialista. Le “cineserie” consistettero inizialmente nell’abitudine della ginnastica al mattino e poi nell’affissione di manifesti denigratori. La prima, col suo effetto salutare, non portò nulla di male, mentre i manifesti ci scoraggiarono e danneggiarono anche un mucchio di persone, me compresa. Un’organizzazione di giovani molto combattiva della facoltà di ingegneria, all’improvviso e inspiegabilmente per me, ma non per la guida della Gioventù della facoltà e per altri più in alto, affisse un foglio nel grande atrio del secondo piano proprio nel nostro luogo di ricreazione. Fu criticato il mio aspetto esteriore, che era in totale contrasto con l’estetica del rivoluzionarismo imposta alla gioventù albanese, impegnata in vigorose azioni costruttive e civilizzatrici ovunque in patria. I miei amici del corso replicarono subito, respingendo l’accusa e dichiarando tendenzioso il suo contenuto. Non era mai successo che una risposta non avesse al suo interno elementi di autocritica, tanto più che veniva data dall’organizzazione, non dalla persona attaccata. Questa cosa mi lusingò così tanto che decisi io per prima di non rispondere. Entrambe le posizioni, la mia e quella dei miei amici, dimostravano che, da “veri secchioni”, eravamo troppo distanti dalla realtà del tempo. Non potevamo neppure immaginare quanto si sarebbe prolungata questa campagna di denigrazione, né quanto sarebbe stata feroce.
Notando la nostra fermezza e la mancanza di autocritica, le guide della Gioventù iniziarono a spronare le organizzazioni dei diversi corsi delle rispettive facoltà, perché continuassero la critica contro il mio aspetto troppo “occidentale”. Gli stand dell’atrio si riempirono ancor di più, addirittura fino alle scale. Cominciarono a prendervi parte anche le organizzazioni delle classi operaie della capitale. Le critiche arrivarono, frenetiche. Ricordo alcune dichiarazioni: “Vera non porta semplicemente i capelli legati a coda all’indietro, lei si ispira al modello dei cardinali cattolici di Roma, perché la coda di cavallo forma una croce col fiocco nero”, scriveva un tale molto perspicace. Un altro, ex allievo della scuola media Luarasi, concludeva invece così la sua critica: “Il grande Lenin ha detto: La semplicità nel vestire è un aspetto del modo di vivere proletario!”. In entrambi i casi si faceva riferimento all’idea di semplicità: una criticava il simbolismo attraverso la semplicità sofisticata, l’altra criticava la mancanza di semplicità. Tutti erano liberi di scrivere ciò che volevano sul mio conto, mentre io ero libera di difendermi, anche non rispondendo loro. Continuai ad andare in facoltà con gli stessi vestiti, con lo stesso colore e tipo di acconciatura. Non cambiai nulla, solo mi si spense il sorriso.”
Noi incontriamo Vera in quella che fu la sua casa e che dà il titolo al libro: La villa con due porte. Due porte perché la villa aveva due ingressi separati. Uno, circondato da un giardino fiorito, conduceva al piano terra, che era il piano “nobile”, riservato ai membri dell’Ufficio Politico e alle loro famiglie: pavimento di parquet di quercia e mosaici, incluso quello del bagno più grande. Gli inserti delle porte non erano di semplice vetro, ma di cristallo. L’altro ingresso portava al secondo piano, dove viveva la famiglia di Vera, e al terzo, dove stavano altre due famiglie: quella del cuoco di un membro dell’Ufficio Politico e quella del suo aiuto ufficiale.
Oggi la villa è diventata un bar, che si chiama Kino perché vuole in qualche modo celebrare il cinema albanese “vintage”, anche nell’arredamento. Sono rimaste tracce, però, del parquet dei tempi di Vera. Il locale ospita concerti live di artisti locali, jazz nights, DJ-set e ovviamente serate dedicate al cinema.
Noi ci arriviamo nel tardo pomeriggio, ma il giardino esterno, che ora è ovviamente il dehors del bar, è già abbastanza pieno. Dobbiamo spostarci un paio di volte per trovare un angolino tranquillo dove Vera non debba sgolarsi per farsi sentire. Lei ha più di 70 anni ma mantiene un portamento elegante ed altero: non è poi così difficile immaginarsela quando era una bionda un po’ ribelle, schietta, coraggiosa, forse troppo appariscente e spontanea per il puritanesimo del regime. Parla un ottimo italiano, anche se si schermisce quando glielo facciamo notare e si scusa ogni volta che non trova una parola. Fuma una sigaretta dietro l’altra, e intanto racconta la sua vita da romanzo: l’infanzia nel Bllok, l’università e poi quello che lei chiama “l’esilio”; le sue due nonne così amate e così diverse, il papà che, quand’anche sia appartenuto alla nomenklatura, ha sempre goduto di buon nome presso la comunità dei confinati e dei prigionieri, non solo per la resistenza mostrata contro il regime per tutta la durata della prigionia ma anche, più in generale, per le sue qualità di uomo. E la mamma, che anche quando le fu offerta la possibilità di vivere libera assieme ai suoi figli purché abbandonasse il marito, decise di restargli vicino. Per questo – dice Vera – il suo libro è stato ben accolto dal pubblico albanese. Il padre di Vera, tra l’altro, era originario proprio delle montagne del Nord, dove saremo da domani.
Uno dei ricordi storicamente più interessanti contenuti nel libro è quello della visita di Enver Hoxha. Mentre gli serve il tè Vera, un po’ senza volerlo ma con giovanile sfrontatezza, tocca un nervo scoperto: in qualche modo gli ricorda di non aver mai terminato gli studi. Nel descrivere il profilo psicologico di Enver Hoxha in molti si sono soffermati sui suoi complessi: mediocre percorso di studi, una Resistenza vissuta lontano dal fuoco della battaglia. Complessi che hanno probabilmente contribuito a renderlo fanatico repressore di qualunque tipo di dissenso o anche solo di critica.

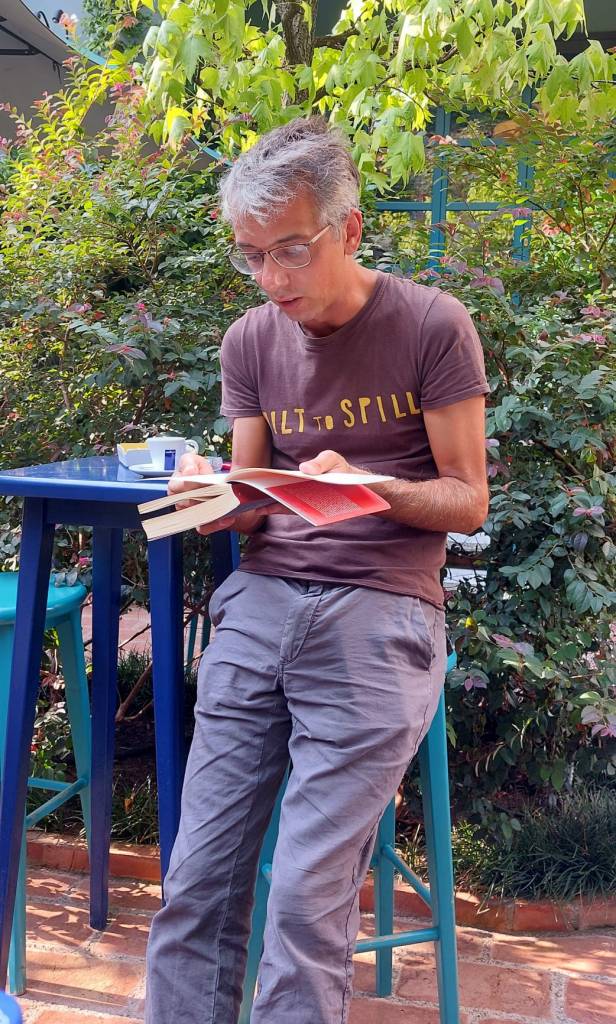



Vera, sempre con schiettezza e umanità, ci ha poi raccontato anche qualcosa della sua vita di oggi in un’Albania lanciata verso il futuro a velocità forse fin troppo sostenuta. L’incontro è stato di enorme interesse per tutti noi ed è continuato a cena, dove lei si è unita a noi per il primo vero assaggio della cucina albanese.
Tra le varie specialità presenti sulla tavola spiccavano le melanzane ripiene stufate dette “dell’Imam svenuto” (Imam bajalldi o imam bayildi in turco). Diffusa in tutti i territori che hanno fatto parte dell’Impero ottomano, questa pietanza è legata a una leggenda turca secondo cui un imam sarebbe svenuto per la bontà del piatto preparatogli dalla moglie.


Musica di sottofondo fornita da un trio di musicisti locali: ovviamente musica albanese, ma non poteva mancare anche qui un po’ di Italia: prima Bella Ciao, alla quale ci siamo uniti con entusiasmo, e poi, proprio mentre stavamo uscendo, Tirana è diventata Napoli, forse in omaggio involontario al nostro Carlo.
Involontario all’inizio, perché poi, quando qualcuno ha svelato la sua provenienza, si è dovuto suo malgrado esibire con loro in un’interpretazione di ‘O sole mio di cui “purtroppo” manca una testimonianza filmata…
Come primo giorno può bastare; domani si parte verso le montagne del nord, tuttora aspre e culla di una cultura antichissima e affascinante, pur nella sua durezza.
To be continued…

Grazie 1000 Piero, non ci fai solo rivivere il viaggio ma ci accompagni in uno nuovo e più ricco
Al prossimo capitolo
"Mi piace"Piace a 1 persona
Attacco di invidia fulminante x non aver potuto esserci!!!!!
"Mi piace""Mi piace"